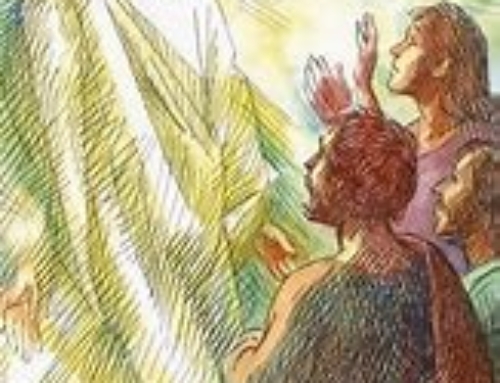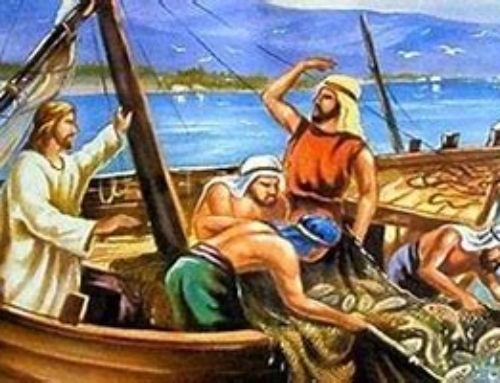Espressioni del tipo “quella persona si è fatto un nome” o “quell’opera porta il suo nome” indicano un modo d’intendere il senso dell’esistenza personale.
Procurarsi un nome che spesso viene associato ad un titolo, ad un’attività economica, ad una creazione o ai propri figli, sembra la meta che rivela il valore di ciascuno.
In un certo senso siamo d’accordo con tale convincimento perché portiamo un’identità sociale legata al nostro nome ma, approfondendo, questo potrebbe equivalere a dare un peso utilitaristico o relativo al valore sociale svendendo la propria identità al migliore offerente.
“A cu apparteni” era un’espressione tipica della nostra infanzia quando in paese incontravamo un adulto che nell’accoglierci ci invitava a dichiarare chi era nostro padre. Quel riconoscimento esprimeva un modo di sentire dettato dall’appartenenza che diceva della differenza e unicità di ciascuno.
Culturalmente quest’uso è sempre più scemato fino a scadere nell’indifferenza che ha ridotto all’anonimato la presenza di un bambino, così come quella di un anziano o di un ammalato, perché il riconoscimento di un individuo viene sempre più associato alla capacità produttiva e all’utile che se ne può ricavare.
La deriva del patriarcato e del maschilismo che in taluni casi ha ridotto il ruolo paterno ad un paternalismo privo di relazione, ha contribuito alla crisi dei ruoli genitoriali e alla liquefazione della figura paterna sempre più assorbita nell’attivismo produttivo per trovare un ruolo all’interno della società.
L’unicità di ciascuno, crediamo, è legata al nome ma questo riconoscimento ha bisogno di trovare piena espressione nell’amore.
Oggi celebriamo la festa di san Giuseppe, figura a noi molto cara che ci rivela la portata dell’identità affidata al nome di ciascuno. Pronunciare il nome altrui è il senso della vita di Giuseppe di Nazareth.
Lui non agisce nel proprio nome, piuttosto, mostra un’identità relazionale, se siamo è perché riveliamo un altro.
Il generare non equivale a possedere ma a custodire e favorire la crescita, siamo chiamati a prenderci cura dell’altro e non a sottometterlo alle nostre prospettive. La nascita di Gesù nel Vangelo è preparata dal riconoscimento di Giuseppe il quale è invitato a non avere timore ma ad accogliere e dare un nome.
Il timore a cui si fa riferimento è l’atteggiamento di chi sa mettersi da parte perché riconosce l’insondabile opera di Dio. Giuseppe comprende che il Cielo sta agendo nella sua promessa sposa ed è allora che consegna il suo progetto d’amore lasciando spazio all’azione dello Spirito.
Questo atteggiamento potrebbe essere equivocato con una sorta di debolezza e invece dimostra la profondità di un uomo che non rimane dominato dai suoi progetti ma rimane in ascolto della volontà di Dio sebbene non abbia comprensione di quello che sta accadendo. Al contempo cerca di procurare le condizioni favorevoli permettendo a Maria di allontanarsi nel segreto senza esporsi al pericolo della condanna.
L’angelo nel sogno lo invita, anche, a dare nome al figlio. Riconoscerlo con la consapevolezza che non gli appartiene.
La paternità di Giuseppe è indicata con il dare nome a Gesù. Mentre la madre lo accoglie nel grembo il padre è chiamato a chiamare per nome esprimendo così il riconoscimento gratuito.
L’esistenza personale ha puntualmente questo duplice tratto identitario, un’accoglienza che è dettata dall’appartenere simbioticamente alla madre, al suo corpo, e al contempo un separarsi per aprirsi all’altro da sé, colui che con la sua parola restituisce cittadinanza in questo mondo.
La parola dell’altro che ci sta di fronte è fonte di riconoscimento, esprime l’apertura alla relazionalità e questa permette l’individuazione e cioè il sentirsi unici perché diversi, separati, visti da uno che è altro dalla madre.
Giuseppe offre uno spazio di espressione e di custodia. Certamente i primi anni di Gesù saranno stati segnati da questa relazione che gli farà da specchio, speculare a quella che poi sarà l’intima relazione con il Padre che è nei cieli, tanto che sarà additato come “il figlio del falegname” e, anche per questo, non creduto quando parlerà del “Padre suo”.
Guardando la figura di Giuseppe di Nazareth approfondiamo il senso dell’incarnazione perché Dio assume la nostra fattezza mischiandosi pienamente nella vicenda umana. È così che possiamo leggere anche le dinamiche all’interno della famiglia di Nazareth la quale si ritrova a questionare anche sull’assenza del figlio quando temono di averlo perduto e lui ricorda “non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. Vi troviamo la dialettica necessaria per la crescita e la definizione di sé, ogni padre è confronto e confine che permette al figlio di trovare la sua strada.
Il limite è necessario affinché ciascuno possa assumere liberamente la propria direzione di vita.
Giuseppe sarà custode e consegnerà alla sua missione il figlio. Non ne avremo più traccia nel Vangelo ma la sua testimonianza rimane eloquente perché ha favorito l’espressione e il dono del Figlio di Dio.