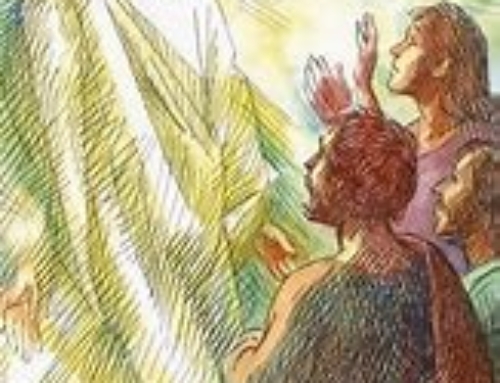L’animo umano oscilla tra la stanzialità e bisogno di ripartenza, tra necessità del viaggio quale condizione esistenziale e desiderio di un rifugio in cui ritrovarsi. Questa tensione, intendiamo bene, non si riferisce esclusivamente al trasferimento da un luogo ad un altro ma anche al movimento interiore che fa della vita una continua ricerca in vista della meta.
Si pensi, ai nostri giorni, quante migrazioni di popoli attraversano il Mediterraneo, l’Africa, l’est europeo o il sud America, quanta precarietà nelle relazioni umane o nell’occupazione lavorativa, nei cambiamenti sociali o nelle condizioni climatiche, e come esse attendino accoglienza e l’offerta di un contesto, prima di tutto umano, dove ripararsi.
La precarietà esistenziale, dunque, abbisogna del passaggio al “noi” inteso come responsabilità civile nel generare comunità ed inclusione. Nella solitudine propria dell’isolamento non c’è benessere e abbiamo tutti bisogno di una dimensione comunitaria per trovare approdo e continuare a rimanere fecondi di vita. Lì sperimentiamo l’occasione per la solidarietà e la gratuità, per la trasmissione e la condivisione dei saperi e tutto questo nutre il viaggio esistenziale e fa rimanere liberi.
La libertà è propria di chi sceglie la direzione del cammino, il bisogno di navigare oltre e di tenere a bada la nostalgia di approdare a riva. In questo travaglio esistenziale si gioca il senso della vita e la spiritualità a cui prestare ascolto.
Troppo spesso ai nostri giorni scopriamo questa libertà e capacità di ricerca negata, è il dramma della guerra armata così come quello dell’espropriazione dei propri diritti, primo tra tutti il diritto di cittadinanza.
Quello che sta accadendo in Palestina è solo un esempio di questa violazione del volto umano, dopo una guerra che dal 7 ottobre 2023 ha ha mietuto oltre 50.000 morti si torna a parlare di trasferimento volontario o coatto degli abitanti di Gaza, di quel che resta almeno perché il territorio è coperto di macerie.
La mediazione di pace si trasforma in un’artificiosa conquista che espugna terre e impone il controllo militare da parte di una nazione che mira ad espandersi oltre oceano con il miraggio della “Riviera del Medio Oriente” quale luogo di festa per i facoltosi turisti di ogni parte del mondo…
C’è chi rinuncia alla propria libertà sottomettendosi al potente di turno per garantirsi il quieto vivere, chi sceglie l’indifferenza quale via per la propria tranquillità. Simile posizione spegne la passione per la vita e distrugge la comunità umana riducendola ad un’anonima acquiescenza.
Chi si confronta con il Vangelo è destato da una simile sonnolenza e restituito alla dignità del vivere. Nella pagina che meditiamo in questa domenica (Lc 5, 1-11) emerge la provocazione che Gesù fa ai suoi discepoli e, con loro, all’umanità intera.
Li trova su due piccole barche, sono pescatori ed è in quella condizione esistenziale che li incontra. La barca è strumento di transito per attraversare il mare ed arrivare all’altra riva, per loro è anche a servizio della pesca, per lavorare e sostenersi, dice della quotidianità del vivere segnato dalla cura di ogni giorno.
Sono piccole imbarcazioni quelle indicate dal Vangelo come a mostrare la precarietà del viaggio mai del tutto preventivabile ma che abbisogna dell’ascolto per orientarsi in vista della meta.
Gesù sale con loro, il viaggio non è più solitario ma è accompagnato dal Suo insegnamento, la Parola che restituisce vita. Essa destabilizza perché l’invito a prendere il largo e quindi a gettare le reti in realtà è paradossale in quanto non si pesca di giorno e per di più quando la notte è stata infruttuosa.
Il Maestro, però, invita i discepoli ad uscire dai loro schemi preordinati e frutto del calcolo e dell’esperienza accumulata, la relazione con il Cielo ha altre regole ed abbisogna dell’ascolto della Parola.
Pietro rispondendo “sulla tua parola getterò le reti”, sta compiendo il passaggio della fede che apre ad una prospettiva del tutto inedita perché la fiducia in Dio cambia il modo di discernere e realizzare la propria missione di vita.
Quella che era una esperienza fallimentare, cioè priva di risultati, ora diventa feconda di frutti, e viene utilizzato il termine “concepire” per indicare i “pesci che avevano concepito”. La metafora biblica è riferita all’umanità che va generata a nuova vita perché fino a quando rimane immersa nel mare rischia di sciupare il dono dell’esistenza. Per tale motivo appresso userà l’espressione “d’ora in poi sarai pescatore di uomini” (Lc 5, 10) e cioè tirare alla vita e, così, generare viventi. È l’arte del liberare dal male per tornare alla riva dove è possibile spendere il dono della propria esistenza. Nessuno è fatto per rimanere negli abissi, lì dove luce non arriva. Quando manchiamo della Parola, infatti, ci appesantiamo sempre più andando a fondo e sono quei tunnel esistenziali da cui facciamo fatica ad uscire da soli.
Parafrasando la poesia pedagogica del caro Danilo Dolci riteniamo che ciascuno nasce solo se sognato e a tutti è dato di esprimere in pienezza la propria e irripetibile missione di vita quando ci lasciamo sognare da Dio.